Categorie: Arte e letteratura
Tags: botte I tesori di Guido Racconti
Scritto da: Guido Ghezzi
Commenti:5
LA BOTTE
Questo è uno dei "Tesori di Guido" raccolti nella sezione d'archivio ad essi dedicata
Un ricordo potente m'ha all'improvviso restituito il fantasioso mondo dell'infanzia,
là una botte viveva come un misterioso compagno.
LA BOTTE
(di Guido Ghezzi)
Il risveglio
Abracadabrantesca è la botte.
Abracadabrantesca è nei ricordi lontani.
Taceva.
Arcuato, indeciso tra pienezza di sfera e solennità di cilindro, il vuoto ligneo taceva immenso, greve e incupito da tre stagioni di ritiro in cantina.
Rimembrante, forse, dei murmuri silvani, all’urgere dell’autunno il rovere veniva rimosso dall’oscurità e riportato alla luce come un misterioso vivente, in ceppi per un immemore misfatto. Grandi sforzi accompagnavano la liberazione, quasi accolta con sofferenza, salutata da lenti cigolii, schiocchi, rantoli e cavernosi brontolii fino all’irrompere dell’aria nuova nel ventre, gonfio di vetuste stagnazioni.
Giaceva dunque, il liberato, sul fianco al sole, arduo dire se per timore di affidare il peso ad un piede insicuro dopo tanto incancrenire nella cella o per godere dell’ultravioletto beneficio sulla scorza irta di grumi immondi, sarcofagi d’insetti, marciumi rugginosi e calcificate polverosità.
In tal posizione veniva sottoposto all’iniziale e sommaria ispezione per valutare natura e gravità delle affezioni, primariamente devota a stabilire se l’amara inazione, complice l’età, avesse minato senza rimedio l’integrità del corpo legnoso, se talune terebrazioni qui e là manifeste spingessero l’intacco nell’alburno profondo.
Licenziato il primo momento di apprensione per la sorte del redivivo, già accolto come un compagno promissorio di inediti passatempi, s’assisteva al suo lento riconquistare la stazione eretta.
Esso tornava, finalmente, all’antica complessione.
Rinvigorito pareva stendere le membra, enfiare il ventre, manifestare austero l’inaudita sua capienza, tronfio dilatare le centine dopo la penosa costrizione. Ora andavano accertate talune gibbosità, intumescenze e umboni, temuti sintomi di infiacchimento assai più delle rare concavità.
Il martello provava quindi l’elasticità dell’epa smisurato, ne forzava i punti sfiancati, percuoteva, ribatteva e riaggiustava. Il buzzo rispondeva con sonorità cave al repentino riallinearsi delle centine sotto i colpi di maglio; suoni tellurici scuotevano il vacuo budello, affioravano all’immane cerchio buccale e tracimavano in larghe vocali cedute all’aereo dissipare.
L’Imponente, sopportato infine l’ultimo travaglio con stoico tacere allo stringere dei cerchi ferrigni sui fianchi, s’abbandonava al riposo nell’ombra calante sull’aia, dominata al guardo con tesa fierezza.
L’abisso
L’indomani la botte era pronta a sostenere l’onere.
Con certa guardinga bonarietà presidiava il vertice del cortile, quasi ne fosse il sovrano in virtù di recente investitura, consigliato a manca da una rosa rampicante e a destra da un’ortensia, rilassata e meditabonda.
Il Gigante sonnecchiava in attesa di dar prova dell’enorme capacità del suo ventre, dell’ancora vigorosa tensione del dorso.
Al momento, tuttavia, non avrebbe ospitato altro che acqua, necessaria al fine di stagnarne, sigillarne, astringerne anche la più invisibile capillarità dovuta al lento disseccare del legno nel lungo e solitario inoperare, da poco interrotto.
L’acqua, fornita senza fretta da un tubo, pareva inghiottita all’infinito; un fiotto dopo l’altro scompariva nella bocca spalancata, s’ingrottava nel vuoto, precipitava nell’ombra ipogea con un frastaglio di crosci e tonfi. Dopo ore un tranquillo cerchio liquido affiorava al bordo superiore, segno che l’inestinguibile sete era finalmente saziata.
L’enorme pancia ostentava ora contegnosa soddisfazione, appena stemperata da un gocciare inferiore, da un persistente stillare, da un sudare all’accosto delle centine. Per nulla turbato dalle
molteplici perdite, il Reggente dell’aia confidava nel rigonfiarsi dell’epidermide che avrebbe presto soffocato le trascurabili emorragie. Il totale rinserrarsi delle fessure avrebbe sancito la completa stagnazione dell’involucro e con essa la riconquista del pieno diritto a ricevere l’agognata materia.
Pur di minima entità di fronte a tanto volume liquido, le fuoriuscite drenavano inesorabili per giorni il possente corpo, deprimendone la pienezza e rendendo necessari continui rabbocchi affinché il livello rimanesse sempre a sfioro del bordo superiore.
Così repleta, la botte poteva finalmente mantenere quanto tacitamente promesso all’immaginazione fanciullesca, avida di nuovi passatempi e di potenti compagni.
Troppo elevate per stature non adulte, le sponde circolari del lago venivano raggiunte a mezzo di compositi sopralzi, contrafforti edificati con malferme invenzioni, messe in opera sul momento saccheggiando l’intorno. Finalmente a portata la superficie acquea appariva all’occhio furbesco come una caldera d’insondabile profondità, un immaginifico abisso oscuro, vagamente minaccioso e custode di mostruosità dormienti sul fondale. Quali leviatani ristavano in paziente attesa nei recessi più fondi? Quali potenze quiescenti erano occultate dall’immane spessore liquido?
In principio l’abisso andava scandagliato palmo dopo palmo nella sua porzione più superficiale, la più accessibile e amica, trasparente e riverberata dalla luce. Più in profondità non era ammessa profanazione, nell’inosabile subacqueo si stendevano il silenzio e l’ombra e sotto ancora la tenebra, percorsa da pigre correnti. Era oscurità solida, muta e densa, verosimilmente agitata da arcaiche forme animate. Da quel regno di pressioni inimmaginabili forse la notte sarebbero risalite nottiluche amare, straniere fosforescenze, predatori dall’incerto mutare, manifestazioni di remote biologie, ignoti rapitori dai pensieri transitori e fatali.
Esauriti i prodromi esplorativi il gioco prendeva dunque le mosse, con entusiasmo appena incrinato da una certa strisciante inquietudine. Vascelli d’ogni forma e misura affrontavano il mare, dal minuscolo gozzo ricavato da un mezzo gheriglio al filante sciabecco di corteccia alla risoluta caracca, irta di velacci.
Il naviglio donava nuovo senso al cerchio d’acqua morta, ora vivificato da intrecci di trasporti, arrembaggi, manovre, attracchi, urla di ciurma, accosti, rollii e beccheggi. Dapprima con deferenza consapevole dell’abisso tenebroso sottostante ma col passare del tempo sempre più confidente, ogni timoniere assaporava il fendere della prora sulla bonaccia….le tracce gemelle divaricare dalla chiglia…..le murate immergere fino all’estremo limite del galleggiamento….
A tanto compiaciuto divertimento s’accompagnava, talvolta, l’inevitabile insidia.
Improvvisa giungeva la procella a sconvolgere le acque; un gran sciabordare disperdeva la flottiglia, adunchi marosi fustigavano i vascelli, li spingevano alla deriva, strappavano controfiocchi e pappafichi, mozzavano alberature.
Infine la mano del caso apriva gorghi inauditi. Imbuti voraci risucchiavano le imbarcazioni, le rilasciavano e le riafferravano in un caos drammaticamente orchestrato ma teso alla salvezza generale.
A scorno di tanta garante regia, però, un guscio finiva all’occorrenza preda di impreviste correnti; scivolava nell’imbuto spalancato, fremeva un istante sull’abisso, rollava e veniva inghiottito. L’epiglottide liquida si richiudeva sul natante, questi s’avvitava due, tre volte nel mondo subacqueo, sfuggiva alla presa salvifica d’un braccio prontamente immerso e scompariva nell’oscurità del fondo, ormai irraggiungibile.
Lo sbigottimento per la tragedia, benché profondamente accusato, durava il breve tempo necessario all’acquietarsi della tempesta, non più alimentata dal mulinare delle mani nell’acqua. Prima di tornare al gioco le imprese della barca perduta ed i tanti viaggi venivano novellati con cordoglio, le circostanze con sussiego declinate e lo spirito d’ogni perduto affidato alle Nereidi.
La sera un misterioso silenzio scendeva sulla liquida superficie, talvolta rischiarata da tremori lunari.
Una straniera sospensione temporale avvolgeva le sponde, ne vegliava la pace e i segreti là deposti dall’ortensia e dalla rosa.
 Alchimie
Alchimie
Il Monarca panciuto regnava sul cortile per una settimana, al più dieci giorni.
Ormai perfettamente sigillato dal turgore ligneo e quindi pronto al nobile servizio, veniva svuotato dall’acqua.
Un’ultima procedura andava ancora espletata per rendere del tutto inerte il contenitore, per dissolvere le residue spore fungine nascoste tra le bisellature e altre invisibili putredini.
Gialle candele di solfo venivano accese in un crogiolo di peltro, ammaccato e butterato.
I vapori sprigionati dalle cerose accrezioni s’insinuavano maligni nel grande ventre, capovolto sulla fornace, e la disinfezione prendeva l’avvio. Il paziente mostrava di tollerare a stento le fumigazioni. Ad ogni sbuffo l’aggressione delle esalazioni penetrava in profondità, vasti e acri bruciori diffondevano nei visceri, ulceravano contaminazioni e muffosità, riducevano ossidazioni, disseccavano gli ultimi alveoli carboniosi.
Ottenebrato dall’infernale mal’aria ma cupamente consapevole della necessità del supplizio, il Colosso, terminato il calvario, veniva infine trasportato al coperto e issato su di un solido scanno.
La spremitura dell’uva era operazione di poco conto, un banale macerìo, un semplice ridurre la materia ad uno stato preparatorio alla successiva e ben più impegnativa fermentazione, che andava invece accudita dalla botte con attenzione e solerzia, ospitata e protetta con diligente benevolenza. In quella breve settimana di ribollire saccarino si compiva l’atto supremo; un fallimento avrebbe reso vani la lunga reclusione e il faticoso risveglio, insensate le feroci torture preparatorie.
Nessuna estraneità era tollerata nella cascata di reazioni, catalisi e ossidazioni responsabili della metamorfosi. I lieviti andavano nutriti dalla gran massa di polpa, bucce e raspi, andavano delicatamente cullati, indotti a proliferare, andavano ossigenati, aerati, salvaguardati dalle anidridi; l’esuberante potassio andava spinto a tartarici connubi, sfamato e precipitato al fondo, gli alcoli elevati alla superficie.
A tale complesso compito il Gigante presiedeva con stagionata competenza, lasciando trapelare del frenetico lavorìo confinato nei suoi visceri soltanto un bonario tepore.
Egli non poteva più essere compagno di imprese nautiche, ora. Troppo impegnato nel compito, massimamente assorto nella custodia del mosto. Offriva nondimeno motivi di interesse all’avidità giocosa invitando a poggiare l’orecchio all’immane gonfiore del ventre.
Inquietanti borborigmi si manifestavano all’auscultazione, mentre l’occhio fanciullo roteava sgranato nell’immaginare l’incessante sommovimento della metamorfosi in atto. L’ipogeo ribollire, lo scorrere di bollicine lungo il peritoneo barricato, il sussurro rimescolato dell’attività chimica apparivano ancor più misteriosi poichè nulla traspariva una volta distaccato l’orecchio. La botte ristava immobile sul suo scanno come un Buddha in meditazione, a tratti incoronato da una momentanea esalazione, acre e invisibile.
Giornalieri rimescolamenti erano operati con una lunga tavola dai bordi usurati, vetusta quanto la botte e per metà color vinaccia. All’interno del cratere ribolliva un lago denso e violaceo, occupato al centro da un’isola di raspi corrosi; un intrico scheletrico arso dai vapori della fermentazione che la venerabile tavola, faticosamente manovrata, sospingeva a fondo nel liquido. Il movimento faceva affiorare altre masse informi e scure, liberava flussi pungenti e fumi soffocanti, insidiosi ectoplasmi a guardia dei magmi in trasformazione.
Coda
Allo scemare del subbuglio nel corpo della botte, rivelato da misteriosi segnacoli, un corteo di polverose damigiane dai ventri fasciati di giunco s’apprestava al cospetto dell’Assiso. Dopo un lustrale lavaggio i vetri rilucevano d’uno spesso color clorofilla e allineati nel cortile per l’asciugatura s’animavano di iridescenze solari.
Ad ogni refolo d’aria una canta d’organo s’alzava dai colli allungati, una canta eterea e monotona.
Al fragile grembo delle damigiane spettava accudire la materia lavorata entro il potente ventre della botte; al violento ribollire del mosto s’avvicendava un lento maturare del novello, custodito nell’oscurità e nella quiete.
La botte pareva tuttavia restia a cedere il frutto di tanto impegno, e con ragione. Dopo l’iniziale profluvio di terso rubino, l’emungimento incappava in continui arresti. Vinaccioli e bucce esauste s’assiepavano all’attrezzo sequestratore, frapponevano i loro corpi macerati con veemenza, occludevano l’orifizio vorace e immonde fecce si offrivano al risucchio in luogo del nobile liquido. L’inesorabile depauperamento si consumava in ore di impercepibile sprofondamento del cappellaccio flottante sul mosto, ore scandite dall’avviarsi alla clausura delle damigiane, ora pingui e una dopo l’altra riposte nell’ombra più zitta e fonda della cantina.
Il gran corpo s’infiacchiva.
Privato della linfa vitale quasi pareva afflosciarsi, pativa il saccheggio coll’animo tristo e come un sovrano decaduto rimuginava sull’esilio ormai prossimo.
Il singulto di dense bolle gassose intercettate dallo scandaglio sanciva infine l’esaurirsi degli ultimi e più riposti giacimenti liquidi; con gesto cauto e misurato veniva rimosso lo zaffo al piede.
Ne sfiottava un latticello cremisi, un opaco concentrato di decantazioni catalitiche, scorie e fecce, filtrato per recuperarne la minoritaria parte nobile da affidare all’ultima damigiana.
Disseccata da ogni umore la botte veniva adagiata sul fianco e svuotata degli acri residui.
Il gigante riverso rilasciava l’ultima massa solida, un fumante coacervo digerito e punteggiato di vinaccioli esangui, pregno di liquori aspri.
L’intensità degli effluvi riscuoteva gli animali domestici dall’ozio del tardo meriggio; tra essi il cane, sempre in cerca d’un boccone dimenticato.
L’ispezione olfattiva lasciava presumere che nulla vi fosse di reale interesse, ma il dubbio pareva insinuarsi comunque assieme ai miasmi delle fecce. La bestia accennava un blando morso, saggiava qua e là il budello incrostato, senza convinzione. Succube della fame, forse patita in tempi remoti, pareva ritenere comunque sacrilego lo spreco, seppure di una materia tanto degradata e già profondamente assimilata dai saccaromiceti. Con lento e fiacco ruminare ripuliva i visceri della botte da ogni residuo finchè, inebetita dagli alcoli aspirati e ingeriti, colta da sfinimento abbassava le orecchie e s’acciambellava ai piedi del Titano reclinato.
Spossati giacevano i due, l’uno vassallo fedele dell’altro, nell’animo ancora sovrano di un regno ormai tramontato.



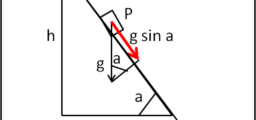


5 commenti
Bel ricordo; tutto vero.Il gigante panciuto ora in meritata pensione ,continua la sua attività benefica come tavolo all'aperto per lauti pranzetti presso cooperativa vinicola in Piemonte- papà Giorgio-
Grazie papà! Furono bei giorni, sono profondi ricordi.
Grazie a entrambi per la condivisione di questo bel ricordo, che ora è diventato anche un po' nostro.
Se vi capita l'occasione, sarebbe bello poter avere una foto recente del gigante per vedere come se la sta cavando nel suo nuovo ruolo di dispensatore di banchetti.
Chissà, poi, cosa starà pensando... se vorrebbe tornare ai bei tempi andati o se si sta godendo con gioia il meritato riposo, se vorrebbe riprovare il brivido dell'incontro con il cane che lo ripuliva da ogni residuo o se è sollevato dal non doverlo incontrare più... chissà... ma forse Guido in cuor suo lo sa e, prima o poi, come solo lui sa fare, ce lo racconterà
che bello questo scambio di commenti sul nostro Circolo (lo è sempre di più!)
Farò il possibile per ottenere una foto del Gigante nel suo attuale regno.