Categorie: Arte e letteratura
Tags: autostrada I tesori di Guido Racconti
Scritto da: Guido Ghezzi
Commenti:2
SINOPIA
Questo è uno dei "Tesori di Guido" raccolti nella sezione d'archivio ad essi dedicata
Percorrendo un'autostrada vidi un tavolino ben sistemato tra le corsie. Invece dell'ovvia considerazione che lì fosse carambolato dal tetto di qualche automobile, finendo per caso ritto sulle gambe, m'immaginai che attendesse d'esser imbandito. Poi, sul quel primo fantasticare, i pensieri s'involarono e ne sortì una storia.

SINOPIA
0
L’estrema luce svanisce lenta, segue il tratturo celeste al traino eliaco, svogliata.
Su questo nastro d’atramento a quattro corsie, ciascuno se ne sta chiuso nel proprio guscio di lamiere, fermo nell’incastro tra chi precede e chi segue.
Qualcuno, con varia indecisione, zittisce il motore ed esce con movenze da paguro; posto a terra il piede, stende il corpo nello strato d’aria più basso e caldo, vagheggia d’istinto altezze e frescure e quasi le fa sue, tra un commento ed uno sbadiglio.
Alla mia destra, però, un distinto signore di mezz’età e abito anglosassone, non abbandona il carapace metallico. L’ho veduto poc’anzi spianare un intrigante volumetto, abbassare ogni finestrino e inabissarsi nella lettura, di tanto in tanto sospesa per studiare con occhi calmi e grigi l’impaccio che ci trattiene.
Nulla saprei dire della sagoma nell’auto che mi precede, invece. Il sole calante m’impedisce qualunque indagine sulla sua corporeità, è solo un’ombra. Lunga e nervosa, pare succube di un’urgenza gestuale che l’obbliga su un canone ricorsivo: poggia il braccio sul sedile vuoto del passeggero, sale al poggiatesta, svalica e retrograda fin al collo, lì tormenta breve un cespo di capelli e torna indi all’originaria esplorazione del sedile, che ancora scopre vuoto.
D’abitudine ripercorro questi luoghi a gran velocità, d’abitudine li ignoro senza motivo. Ed ecco oggi una causa s’è manifestata per fermare la mente su quanto l’occhio ha sempre visto ma mai notato.
Siamo quasi al centro di una estesa depressione, una bassura traversata dalla strada; non proprio nel suo punto più depresso ma un poco verso la cresta orientale. Posso vedere agevolmente ad una discreta distanza: almeno due chilometri volgendomi indietro e un chilometro in opposto verso. Oltre tali limiti la vista mi è preclusa dal profilo che delimita la conca. Vedo bene il nastro stradale che, denso di mezzi, discende dalla collina alle mie spalle e si arrampica su quella di fronte per sparire all’orizzonte, là contrassegnato da un piccolo automezzo di color giallo vivo, posto a quell’estremo come una boa di segnalazione.
Quanti sono i veicoli che vedo? Centinaia. No, forse migliaia. Ma il numero di ciò che la mia posizione permette di rilevare, presumo, nulla dev’essere se rapportato alla quantità che si stende oltre il mio orizzonte sensibile.
Non dev’essere stato un semplice inciampo a fermare la nostra quotidiana marcia, temo.
Un’ora? Due? Tra quanto potremo ripartire?
1
Battono al finestrino. Vengo strappato al sonno. Un volto articola silente oltre la cortina del cristallo. Ovattata mi giunge poi la sua domanda:
- Sa niente lei? –
E’ buio, quasi tutte le automobili hanno i fari spenti, la luce di cortesia in qualche abitacolo evidenzia stanche presenze umane. Abbasso il finestrino, la faccia larga, leggermente butterata sulla fronte e perforata da due occhi di cui non vedo il fondo riformula la domanda, questa volta fornendomi altre esclusive informazioni.
- Del blocco, dell’ingorgo insomma. Ha sentito la radio? Non riesco a sentire una sola stazione…le pare possibile che non ci siano notizie? Che ci abbandonino così? –
Ricordo. Siamo fermi. La giornaliera transumanza dai luoghi di lavoro alle case per i più, da casa al lavoro per altri, s’era interrotta alla soglia del tramonto. Nell’immobile attesa la coscienza era migrata verso il sogno….
La faccia buia parla, senza sosta e ad altra parte volta; non un contributo, seppur modesto, posso apportare alla sua smania, al pari, credo, di ogni altro qui costretto. Lo sconosciuto scuote la testa con nervoso disappunto, si rialza, se ne va.
Esco nell’aria notturna, ora fresca e silenziosa. Il mio interlocutore già è lontano, tenta altri finestrini e ripete l’istanza a me rivolta poc’anzi. Sosta poi procede, inquieto.
L’orologio, consultato all’occasionale barbaglio di un faro, definisce la portata del problema che malauguratamente ci accomuna: tre ore è durato il mio sonno, da non meno di quattro siamo fermi.
In lontananza non vedo che piccoli fanali persi nel buio come fosforescenze scandite sul chilometrico corpo del serpente di automezzi. Tutt’attorno non c’è altro che oscurità e silenzio.
Non proprio.
Non è vero silenzio. In altra occasione l’avrei detto silenzio, ma ora percepisco che non è silenzio. E’ il sommesso brusio dell’esistenza quello che mi circonda e che ho con fretta appellato silenzio. Riconosco il murmure delle fronde, benché sia quasi straniero al mio udito, corrotto dal rumore della vita cittadina. Anche le parole che afferro mentre mi sfiorano il timpano hanno un timbro sconosciuto. Ne ignoro il motivo, ma chi ha qualcosa da dire lo fa sottovoce.
Rabbrividisco.
Torno rapido nell’auto. Ogni tentativo di trarre voce dal corpo della radio fallisce, non una sola frequenza è immune da garbugli sonori e singulti.
Domani saremo su tutti i quotidiani. Una notizia a tutta pagina, così la prevedo. Anzi, già le rotative, proprio ora, la stanno inchiostrando e tra qualche ora viaggerà in forma cartacea per altre strade, deserte nell’ora antelucana.
Battono ancora al finestrino, a destra questa volta.
La fronte butterata si ripropone; nella cerca ha smarrito ogni coordinata del suo sterile esplorare. Un cenno di completa inutilità è tutto ciò che nuovamente ottiene prima di scivolar via. Eclissa qualche fanalino di coda e si perde nel buio.
Alla sinistra si consultano febbrilmente i cellulari ma tosto si lamentano invincibili fallanze di segnale. Non ho motivo d’allarme per questo impedimento, non ho avvisi da lanciare al mondo.
2
Viviamo una condizione ormai paradossale.
L’intera notte è trascorsa senza il minimo fatto.
Il mattino ci trova in condizioni pietose: quasi tutti abbiamo passato la buia parentesi con ben poco riposo, chi tormentato dalla mancanza del proprio letto, malamente sostituito da un sedile reclinabile, chi roso dall’ansia per essere stato proiettato in questo inferno (ci sarà pure un responsabile dell’accaduto da qualche parte), altri sommersi dalle più varie preoccupazioni indotte da questo inumano, feroce, inesorabile sequestro collettivo. I più disparati oggetti hanno iniziato a comparire tra un mezzo e l’altro, in una trasversale e diffusa contaminazione. Là dove è tradizionale dominio delle ruote e dove sarebbe impensabile in normali condizioni trovare una sedia, si ergono tavolini parzialmente imbanditi con generi alimentari raccogliticci, contenitori refrigeranti, giochi, scarpe e persino una tenda in tutto attrezzata.
Si iniziano a scambiare parole con gli occupanti dei mezzi più vicini, chi può offre cibo e bevande, qualcuno è sceso per la massicciata verso un ruscello poco distante in cerca d’acqua. Alla sete forse faremo fronte.
Con il trascorrere delle ore la solidarietà umana inizia a filtrare dalla nostra naturale e moderna diffidenza. Qualcuno ha iniziato a spostare l’auto per garantirsi un po’ di spazio attorno alle portiere. Dopo i primi momenti di sterili contese per queste operazioni, gli episodi di aiuto reciproco hanno iniziato a moltiplicarsi. Ormai sappiamo che dobbiamo cooperare, far solo conto sui soccorsi potrebbe rivelarsi un errore.
Il mio vicino di destra, l’uomo dall’aspetto anglosassone (che ho appreso chiamarsi Rati), è silenzioso ed estremamente tranquillo. Dal suo viso, contornato da un filo di barba grigia, spira un che di bonario. Ascolta gli altrui scambi verbali (che vanno facendosi più fitti di ora in ora e quasi
sempre vertono sulla stranezza dell’attuale situazione), talvolta sembra sul punto di dire qualcosa, un leggero tendere prelude allo schiudersi delle labbra, ma subito scuote il capo e rinuncia, ricadendo nella sua naturale rilassatezza.
Abbiamo avuto lunghi e pacati colloqui in cui ho avuto modo di apprezzarne la cortesia e la controllata misura dell’eloquio. Potevo essere meno fortunato ed avere come vicino ben altro personaggio. Provenendo dalla medesima località abbiamo convenuto di frequentarci anche quando tutto questo avrà termine. Perché ad un termine si dovrà presto o tardi giungere, questa è un sicurezza che nessun argomento può incrinare.
Verso sera Rati s’è avvicinato e mi ha mostrato una piccola scacchiera tascabile, aggiungendo con posata soddisfazione che i riquadri bianchi e neri nascondevano piccoli magneti, il che rendeva l’oggetto di particolare utilità nei momenti di “sosta” o nei viaggi in treno. Ma, lamentava, spesso l’utilità del prezioso oggetto veniva mortificata dalla estrema difficoltà di trovare un compagno di viaggio disposto a misurarsi in una partita.
Non posso dirmi un giocatore di dama e ancor meno di scacchi, tuttavia ho acconsentito ad una partita, più per cortesia che per reale interesse.
3
L’assenza di notizie non è sopportabile oltre.
Nessuna voce fa ritorno. Proveniente da qualche parte e innumeri volte ripetuta una domanda è giunta fin qui: “Cosa è accaduto?”
Il latore ha pregato di passare la voce innanzi, verso gli altri mezzi che risalgono il declivio fino all’auto gialla. Presto o tardi la domanda di passo in passo perverrà al punto dove origina l’anomalia, il punto che ha sperimentato l’intoppo nel meccanismo. Da lì viaggerà nel verso opposto la risposta, che ripeterò poi a chi sta dietro di me.
Un agile stratagemma che al momento resta inesitato. La risposta ancora non mi è giunta.
Considero due sole ipotesi, entrambe inverosimili e perciò inaccettabili: là dove si è materializzato l’imprevisto non v’è possibilità di fornire risposta alla domanda (forse perché qualcuno l’ha sequestrata ed intende mantenere questo stato di cose?), oppure essa ancora sta viaggiando e ciò significa che non si tratta di un guasto stradale.
Ben altro dev’essere accaduto, qualcosa deve aver tranciato le comunicazioni, reso all’impotenza consolidati meccanismi di controllo, imposto superiori emergenze di fronte alle quali la nostra situazione diviene solo un trascurabile inceppo.
Forse il disagio non è limitato a noi. Siamo isolati e pertanto semplicemente incatenati in una condizione ignota a chi potrebbe assisterci, o piuttosto altro non siamo che uno dei tanti episodi conseguenza di una ben più vasta disfunzione che ha colpito il nerbo dello Stato? Forse non saremo mai aiutati perché nessuna struttura di assistenza è più operativa, lo Stato stesso potrebbe aver subitaneamente incontrato la sua fine, come un migratore impallinato a mezz’aria.
Ma non può essere!
Simili pensieri disfattisti vanno scacciati, relegati agli estremi del campo delle ipotesi, anzi neanche considerati come plausibili. Su questo insistiamo, invocando a sostegno della nostra convinzione l’inequivocabile e consolidata buona salute ostentata dalla nostra società fino a pochi giorni prima. Altri sostiene, invece, come i prodromi fossero sotto gli occhi di tutti, semplicemente e testardamente ignorati dalla massa ma presenti; la malattia minava lo Stato indebolendolo e aprendosi sordamente la via verso il suo cuore. Una volta reso cavo, ridotto ad una semplice e fragile corteccia, l’albero, falsamente maestoso, sarebbe crollato al minimo spirar di vento. E con lui noi, tordi sonnacchiosi, miopi ingannati dalla possanza del tronco e dal rigoglio della chioma.
Ma, come dicevo, non va dato campo al disfattismo, è normale un primo momento di sbandamento, bisogna abituarsi alle mutate condizioni dell’ambiente circostante. Abbiamo reagito bene, con l’esclusiva capacità di adattamento che ha consentito all’umanità di misurarsi, e vittoriosamente, con ininterrotte sfide fin dal paleolitico. Esaminare il problema, elaborare un
procedimento, agire e via via raffinare la soluzione attraverso un produttivo processo di tentativi, correzioni e successivi aggiustamenti, fino ad arrivare ad un soddisfacente accomodamento.
Il problema del cibo, come prevedibile, s’è fatto impellente non appena terminate le poche cose commestibili presenti a titolo di viatico. La presenza di un autocarro carico di pomodori, cipolle, carote, pesche e susine non è passata inosservata. Si è preso contatto con il conducente per la spartizione d’ufficio di quanto trasportato. L’azione, altrimenti indegna, ci è parsa ampiamente giustificata dall’eccezionalità della situazione e sostenuta dal superiore principio del beneficio comune. Purtroppo è stato necessario minacciare l’autista che tuttavia s’è rivelato individuo di larghe vedute ed ha infine acconsentito all’operazione richiedendo in cambio solo una firma in calce ad un documento, appositamente redatto su un foglio di taccuino, in cui egli veniva manlevato da ogni responsabilità in ordine alla garanzia dell’integrità della merce. Pomodori e pesche e tutto il meraviglioso carico sono stati accolti come una vera delizia dopo giorni di frugali pasti a base di gallette, sconce merendine e caramelle balsamiche che altro effetto non hanno sortito se non quello di riesumare ricordi fanciulleschi, riportati in superficie dal fondo melmoso di lontane memorie.
Nonostante il piacevole diversivo promosso da questa pausa di alimentazione salutista la nostra situazione psicologica non è migliorata. L’essersi rifocillati ha fatto anzi passare momentaneamente in secondo piano il problema del cibo e ci ha spinto ad esaminare in modo approfondito quanto al contorno di questa nostra condizione. E l’analisi non ha purtroppo condotto ad altro se non a renderci pienamente coscienti di uno stato di estrema precarietà e impotenza che ci ha precipitato nella frustrazione.
Sappiamo bene di essere in una zona semidesertica, disabitata e priva di altre strutture che non siano la maledetta strada su cui siamo incollati come uccelli al vischio. A parte il piccolo ruscello che sottopassa la massicciata proprio qui vicino, non ci è nota altra presenza di acqua utilizzabile, il che rende terribile il pensiero che questa vivagna in realtà sia solo un avventizio rigagnolo. Come possiamo tentare di allontanarci? Per quanta acqua riuscissimo a tradurre con noi non sarebbe sufficiente che a coprire l’esigenza di qualche giorno. Siamo condannati all’attesa, si guarda nervosamente al tetto giallo dell’automezzo in cima alla collina là davanti, sperando di cogliere un suo movimento, ma presto avremo ben altro di cui preoccuparci.
5
Quattro di noi sono partiti con l’intendimento di indagare oltre la collina e riportare notizie. Li abbiamo attrezzati di tutto punto, o quantomeno al meglio possibile; sappiamo che dureranno non poca fatica. Il paesaggio è aspro ma una volta superate le alture all’orizzonte dovrebbe presentarsi migliore, per quel che si ricorda.
In molti condividono la medesima impressione: che la landa qui attorno s’inaridisca passo passo, come se il tempo la consumasse e la stesse mutando via via in un luogo sempre più ostile. Una deriva geologica del tutto normale, si dirà. La scorza terrestre ha vissuto inenarrabili traumi e stravolgimenti fin dal primordiale suo consolidarsi: da fosse oceaniche son sorte cordigliere formidabili, il disseccamento ha mutato interi mari in distese di evaporiti, pieghe e faglie han rugato ogni angolo del volto terracqueo. Ma tutto ciò ha richiesto abissi di tempo inconcepibili; sotto l’angusta visuale umana, all’opposto, tutto è rimasto immutato. E quindi a cosa dobbiamo questa nostra impressione di un luogo che corra nel tempo e muti a gran falcate mentre per noi ogni secondo è eterno? E’ realtà ciò che vediamo o un crudele miraggio?
I quattro arditi hanno un’abbondante scorta di acqua e tenteranno di trovarne altra lungo la via, se non altro il loro rapporto ci servirà per sapere di quanto possiamo allontanarci dall’avaro ruscello.
Viviamo in un gioco di scatole cinesi, attendiamo il passare delle giornate mentre attendiamo il ritorno degli esploratori, mentre attendiamo che il tetto giallo accenni ad un movimento che ci liberi.
Nei giorni passati molti non hanno retto al supplizio ed hanno tentato di allontanarsi nonostante le esortazioni a dismettere un simile azzardo, cieco e con ben poche speranze. Hanno abbandonato i
loro mezzi, con fastidio ci hanno autorizzato a prenderne possesso e disporne a nostro piacimento. Il carburante è la cosa più importante, serve per riscaldare l’abitacolo nelle notti che di tanto in tanto sono fredde e umide; i mezzi vengono spostati e giustapposti, le portiere asportate in modo da ricavare spazi riparati più ampi.
Nella pece notturna studio le costellazioni per trarne informazioni sull’avanzare del tempo; basterebbe dare un’occhiata alla data sul quadrante del mio orologio, è chiaro, ma trovo meno frustrante seguire il passo siderale nel suo reclinare notte dopo notte. Un’attenzione arcaica, più consona a questo vivere lento, monotono e senza apparente significanza.
Rati dorme sul sedile semireclinato. Riposa rigido come un automa cui sia mancato elettrico alimento e al mattino lo vedo risvegliarsi nella medesima posizione della sera precedente. Condividiamo buona parte del giorno, come tanti altri fanno. Spiriti affini si son raccolti in esigui gruppi; hanno avvicinato le automobili, condividono le poche cose utili ed attendono in un silenzio irreale. Non ci sono contestazioni degne di nota, nessuno scontro, nessun atto sconsiderato. Il sistema si è purgato autonomamente, le anime ebullienti lo hanno abbandonato per prime, non tollerando ulteriormente l’oltraggio di questa anomalia dello spazio e del tempo.
Nutrirsi non è semplice, ma riusciamo a rifornirci giornalmente di radici, erbe e bacche; la carne viene rimediata con difficoltà ma costantemente ed il ruscello è incredibilmente pieno di sprovveduti pesci che catturiamo con le mani.
Non passa giorno che il mio occhio non si spinga all’orizzonte indagando la posizione dell’automobile gialla. Questo è il rito che schiude la giornata da mesi, questo è l’irrazionale ultimo volgersi del capo ogni sera prima del sonno. Non mi aspetto di vedere alcunchè di nuovo, sia chiaro; quella minuscola virgola gialla non accennerà mai al minimo movimento, non è ragionevole sperarlo, non più. Tuttavia non sono in grado di astenermi dal compiere questo gesto.
8
Finalmente.
Due di coloro che erano partiti tre settimane fa han fatto ritorno.
In base allo studio delle cartine stradali avevano deciso di avviarsi in direzione nordest, in modo da tagliare l’ampia curva descritta dalla strada, passando attraverso la striscia di colli che fiancheggia questa valle. Avrebbero in tal modo potuto ottimizzare i tempi di percorrenza e raggiungere un punto d’osservazione molto avanzato.
Il loro aspetto illustra eloquentemente la fatica che l’impresa è costata. Degli altri due nulla si sa. Terrorizzati all’idea di tornare al punto di partenza han preferito continuare, pur in totale assenza di riferimenti cartografici e già ridotti allo stremo dalle privazioni. Il resoconto dei due superstiti è stato ascoltato in silenzio; con orrore e sbigottimento abbiamo così saputo che l’immane teoria di mezzi fermi, o meglio di ciò che resta di essi, supera la lunghezza di un centinaio di chilometri, e prosegue ulteriormente perdendosi nell’arida pianura fin dove i loro occhi hanno potuto spingersi. Ovunque le stesse condizioni, lo stesso desolante panorama di mezzi uno vicino all’altro, alcuni ormai abbandonati e già parzialmente smontati e decomposti per farne ulteriori e migliori ricoveri; a perdita d’occhio microscopici agglomerati umani formati per coalescenza attorno a qualche animo forte, gruppi di disperati aggrappati gli uni agli altri come foglie spinte dai venti contro un sasso. L’acqua è scarsissima e presente solo in rivi che difficilmente potrebbero garantire una portata utile nelle stagioni secche; il nostro ruscello pare essere l’unico a regime perenne, per quanto ciò sembri assurdo, mancando rilievi significativi e sbucando da un anfratto del terreno poco più a monte. E’ presumibile che con il diradarsi delle piogge questo divenga un punto privilegiato, meta degli altri malcapitati che non potranno più contare su una costante riserva d’acqua fresca.
Dunque è così. Siamo prigionieri in uno spazio avaro, un reclusorio che sembra dilatarsi enigmaticamente ad ogni nostro tentativo di approfondirne la conoscenza. Lo spazio d’attorno si espande, offrendoci una libertà immensa, persino spaventevole. Ma di quest’ignoto spazio non possiamo in realtà fruire, la sua vastità è invero il più invalicabile cancello. Eppure quanti di noi in
passato lo hanno traversato più di una volta correndo con la propria auto senza guardare? Tutto sembra diverso, trasformato da un maleficio sconosciuto, retto da un sortilegio contro le leggi di natura. Questo luogo, pur concedendoci assai poco, ci consente di sopravvivere. La situazione inoltre consiglia di risparmiare ogni energia, moltiplicando così le difficoltà, aggiungendo ad ogni più semplice operazione quotidiana un ineliminabile fardello, il che rende la condanna ancor più dura.
La sera è calata sui nostri pensieri abbandonati all’inesausta corrente di questo impassibile destino.
13
Talvolta giungono voci cui non saprei dare il giusto peso.
Ieri pareva che qualcuno avesse scorto un moto del tetto giallo in cima alla salita là davanti; un lento scorrere, un appena percettibile slittare, logica conseguenza dell’aprirsi di un varco, di un nuovo spazio tra il mezzo giallo e quello immediatamente precedente, di cui possiamo solo immaginare l’esistenza, celato dietro il colmo della collina all’orizzonte. Questa novità ha sollevato un’onda di entusiasmo che si è propagata per tutte le automobili e si è persa in distanza, scorrendo su questo nastro nero. Ma è stata cosa di un attimo. Ben presto s’è capito che di allucinazione doveva trattarsi. Con malumore abbiamo accolto il feroce inganno ai danni dei nostri esausti nervi. Gli occhi di qualcuno han percepito ciò che egli agognava spasmodicamente da troppo tempo, purtroppo estraendolo dai fantasiosi recessi della sua mente e rendendo reale movimento quel che altro non era se non un semplice tremolar d’orizzonte, promosso dalla beffarda convezione di masse d’aria riscaldate al sole.
E’ chiaro che le nostre menti stanno ormai perdendo la capacità di valutare correttamente gli accadimenti. Forse sarebbe un beneficio, l’unico che ci è permesso, il solo in cui possiamo confidare…..Certo! Che la pazzia infine ci soccorra, ci slacci da questa costrizione e liberi i nostri pensieri nell’aria fresca. Elevarsi oltre la coscienza e sfumare nel chiarore zenitale è il nostro segreto e inespresso desiderio; lasciare per sempre il dolore di questa consapevolezza terrena che non ci uccide ma neppure concede salvezza, centellinando per noi l’illusione di una stilla di speranza ogniqualvolta giungiamo al confine estremo della resistenza.
A poco a poco stiamo scoprendo i limiti della nostra corporeità, e mai avremmo immaginato di poter sopportare tanto e con tanta noncuranza. I nostri ricoveri malfermi e cadenti divengono gelidi loculi nelle giornate di pioggia o neve. Finchè possiamo rimaniamo quindi all’aperto, incuranti dei freddi, dei venti, dell’umidità, ci esponiamo all’inesauribile consunzione causata dagli estremi stagionali. La nostra pelle è segnata, invecchiata, erosa come la superficie delle rocce circostanti, e come esse sembra ossidarsi e cambiar colore, lentamente ed inesorabilmente. E con essa anche la mia anima va facendosi diruta. Ne percepisco lo scolorire, il cedere l’indimostrabile spazio al vuoto, afflitta da una progressiva diluizione, risucchiata in una sospensione di significato che potrebbe, realizzo con orrore, non trovare più riscatto alcuno. Infine anch’essa sarà una rigida trasparenza di crisalide.
21
E’ stato un evento senza precedenti!
Ecco il fatto veramente nuovo che ha sconvolto il nostro sonnacchioso trascinarsi. Il destino ora ci ha fornito in modo crudo, senza spazio per dubbi o false speranze, la misura del tempo trascorso da quel lontano momento in cui ciascuno di noi ha fermato l’auto dietro alla precedente.
Ripenso alle mie stesse azioni: prima ho fermato l’auto, dieci minuti dopo ho spento il motore, poi mi sono addormentato per quattro ore (o erano cinque?), poi ho cominciato a parlare con qualcuno, dopo qualche giorno conoscevo bene almeno dieci di loro, dopo un mese l’auto ha iniziato ad assomigliare ad una scomoda tana ed io ad un gigantesco roditore. Poi il problema del cibo è diventato preminente, come per tutti; abbiamo iniziato a cacciare tutto ciò che sembrasse
commestibile, dopo tre mesi le auto erano state quasi tutte spostate e ravvicinate le une alle altre a formare vani coperti più confortevoli, qualcuno ha aggiunto tettoie composte di tronchi e rami prelevati dal bosco. Microcomunità si sono lentamente formate nel corso delle stagioni, pur nel rispetto dei necessari e inviolabili spazi privati.
Ora è nato.
Proprio a poche auto di distanza.
E’ nato il primo bambino, figlio di questo incubo inimmaginabile.
E’ nato quasi con facilità, con la semplicità e la potenza di un gesto ancestrale, grazie alle forze della madre ed alle sue, perché ben poco avremmo potuto fare in caso di problemi. Certo, abbiamo medici, ce ne sono almeno quattro nel raggio d’un chilometro, ma possono contare solo sulle loro mani e sulla loro conoscenza, peraltro in molti casi inutile se non supportata da strumenti adeguati che la tecnologia ha fornito all’uomo nel corso di secoli, ma che a noi mancano. Questa è la nostra vera condizione: quella di chi può contare solo sulle forze primitive che hanno accompagnato l’inizio della storia umana. Troppe volte abbiamo dovuto accettare la nostra impotenza di fronte alla mancanza di un antibiotico, uno specillo, un cronometro, una lampadina, un paio d’occhiali.
Ci siamo assiepati per vederlo, per accogliere questo tassello che mancava a rendere definitivamente completa la nostra insensata parabola.
Con quali occhi avrà guardato quest’emiciclo di esseri malconci, inquieti, smagriti all’inverosimile, incurvati dalla permanenza negli angusti spazi di dimore inadatte, grotteschi e coperti da laceri indumenti? Ci siamo guardati, stupefatti di fronte alla cosa più naturale di tutte, come se persino la suprema legge di propagazione della specie fosse ormai messa in dubbio. Poi, superato il primo momento di tensione, sull’istante di confine in cui l’uomo passa dalla cruda e incolore tensione dell’attesa all’ineffabile risolversi nel suo nuovo ruolo di genitore, abbiamo iniziato a fremere, ad aggirarci nervosi tra i rottami, a roteare d’attorno sbiechi sguardi ….e poi è accaduto.
La nascita ha catapultato molti alle soglie della follia, è stata una scossa di torpedine sulle gambe di un naufrago ipnotizzato dal moto ondoso; l’evento ha fatto riaffiorare nelle coscienze intorpidite la consapevolezza della nostra miserabile condizione.
Ho visto Rati in piedi tra le irriconoscibili carcasse semiarrugginite delle auto, immobile. Ha iniziato a ripetere con occhi fissi e vuoti “Lui non saprà! Lui non saprà!” Poi le sue parole sono divenute un grido indistinto, ha alzato le braccia e si è lanciato in una corsa folle tra i rottami e i tizzoni fumanti dei fuochi. Correva, il povero Rati, come se ogni sua pacatezza fosse tracimata dal corpo, ma mutata d’un colpo in rigurgiti di panico. Correva, poi ristava, ansava con gli occhi grigi sbarrati, toccava ogni oggetto, ogni angolo di ruggine, ogni relitto tra gli infiniti disseminati. E correva di nuovo, sempre più lontano, sempre più folle, finchè è scomparso alla mia vista.
Molti hanno seguito ammutoliti la scena, e dopo un istante di silenzio è deflagrato il finimondo, come se tutto il nostro universo fosse rimasto per un tempo incalcolabile sull’orlo del baratro, in attesa di un semplice poggiar di piuma per precipitare nel caos.
Qualcuno ha levato grida sconnesse; altri si sono arrampicati sui tetti delle carcasse-rifugio; altri ancora si sono scagliati contro i tronchi cavi che usiamo come camini per smaltire all’esterno i fumi dei focolari. Alcuni hanno iniziato a raccogliere le proprie cose ed a preparare una sorta di zaino, un povero involto per sostenersi in viaggio, decisi a tornarsene nella civiltà (ma quale civiltà?). Altri sono caduti vittima di scoppi d’ira e disperazione, sfociati in episodi di autolesionismo. Ho visto l’onda di angoscia propagarsi rapida nelle due direzioni, allargarsi dall’epicentro-Rati e scorrere come un’increspatura su uno specchio d’acqua costretto tra gli argini. Ho seguito il suo multiplo rifrangersi dopo aver urtato a sinistra e a destra contro i limiti della strada per degenerare infine in un inestricabile caos di figure d’interferenza che è risalito fino al tetto giallo all’orizzonte, lo ha scosso ed infine è svalicato verso l’ignoto.
Così è andata avanti fino a sera, tra disordini di ogni genere.
Insieme al crepuscolo ed alla calma è tornato anche Rati, fisicamente provato, graffiato, nudo e curvo. Muto si è ritirato nella sua tana.
Infine si è riflettuto, l’irrevocabilità della situazione è stata nuovamente ed ancor più profondamente accettata. I miserabili zaini pronti per la partenza sono stati disfatti e gli oggetti riposti sui cruscotti delle carcasse (del resto, tra coloro che sono partiti, chi mai è tornato?), gli animi si sono calmati (che utilità v’è nello sprecare energie?), l’ipnotico scorrere del tempo biologico ha ripreso a cullarci (quante stagioni abbiamo visto alternarsi dolcemente?). E dunque si è ripreso a tentare di recuperare al meglio la nostra condizione umana, memori ancora delle comodità che forzatamente abbiamo lasciato quando abbiamo fermato la corsa delle nostre automobili; alcuni invece, complice l’età avanzata e gli stenti, ristanno senza voce, già avviati alle terre dell’oblio.
Ed uno, uno solo, per il quale questa dicotomia non ha alcun senso. Ai suoi nuovi occhi questo è l’unico mondo, l’unica meravigliosa realtà della vita.
34
Con le stagioni si sono succedute nascite e morti, come in ogni società umana che si rispetti, e questo è terribile. Ormai abbiamo tutti gli attributi di una struttura sociale, benchè in forma distorta. Il risultato è un organismo deforme, orribile e moncato, non ridotto alla sostanza di quanto è necessario per sopravvivere ma piuttosto alla quintessenza di tale sostanza. Sappiamo bene che non resisteremo, siamo troppo pochi per divenire una vera comunità, ci mancano le strutture fondamentali, nessuna notizia arriva, neppure da coloro che sono raggruppati da qualche parte davanti o dietro alla nostra posizione (ma c’è qualcuno ancora?). Non ci sono i numeri, non abbiamo una dignità demografica che ci sorregga e non possiamo spostarci, lo stemperarsi in una lenta estinzione è il nostro ineluttabile destino.
A meno che non accada l’incredibile. A meno che qualcosa si muova, che giunga qualcuno dall’esterno a soccorrerci.
Questa è la metamorfosi che persino i nostri appellativi concettuali hanno subito: un tempo fu la nostra situazione di stallo ad essere incredibile, arduo trovare una spiegazione a quel totale collasso della via di comunicazione su cui avemmo la sventura di transitare; oggi è incredibile immaginare qualcosa che possa liberarci da questo sito maligno, sconsiderato pensare che vi sia un motivo per vedere una sagoma nuova discendere la strada verso di noi.
Impercettibilmente stiamo ormai divenendo parte intima di questa realtà.
Non siamo più gli ospiti di un momento; siamo ormai noi che facciamo di questo luogo ciò che esso è, con il nostro testardo permanere in vita, coltivando con sommo sforzo e insufficienti, rudimentali utensili, i pietrosi rettangoli lungo la strada. Resistiamo al freddo, all’umidità che penetra impietosamente i nostri corpi nelle notti, alla fame, alla fatica che mai ci abbandona. Talvolta persino mi par di perdere il ricordo del luogo e del tempo da cui provengo e infine mi convinco che anche questa vita non è un dramma; tutto in fondo si svolge come due, tre secoli fa su qualche remota e sconosciuta frangia pedemontana. Che sarà mai?
E’ solo come tanto tempo fa, che sarà mai?
Reitero questa considerazione ad intervalli regolari; ho scoperto che giova alla mia mente, la rende meno ribelle, più incline ad accettare lo stato delle cose, per quanto pietoso esso sia. Ho tentato di trasmettere questo atteggiamento a Rati, ed egli, ormai confuso tra lucidità e follia, mi ha invece opposto con calma la sua diversa soluzione.
Pare, mi ha detto, che per quanto gli eventi e le condizioni di un sistema possano evolvere in una qualsivoglia direzione, arriverà un istante in cui tutto si muoverà a ritroso tornando a riavvicinarsi allo stato di un tempo. Insomma su tutto regna una ciclicità, benchè di periodo incalcolabile, certamente ben oltre le capacità d’elaborazione umane. Quindi, ha dedotto, se veramente siamo rimasti isolati per un assurdo gioco di casualità, arriverà il momento in cui, per altrettanta casualità, tutto si rimescolerà, e finiremo per riavvicinarci alle condizioni di un tempo. Allora vedremo qualcosa spuntare all’orizzonte, qualcuno arriverà e ci porterà una notizia, un frammento di novità. E saremo liberi.
Poi, quasi a giustificare l’eccessivo suo confidare nel futuro, ha aggiunto che la nostra esistenza potrebbe anche non risultare abbastanza estesa nel tempo, e forse neanche quella delle nuove generazioni. In ogni caso, ha concluso, il tempo scorrerà nella sua più che giustificata indifferenza, il che non farà che risolversi a nostro favore, portandoci sempre più prossimi all’istante vaticinato.
Così ragionando ogni sera nutriamo i nostri macilenti corpi e le nostre diseccate menti.
Guardiamo le spalle del tempo, giacendo tra le pieghe dell’esistenza, con testarda semplicità, come farebbe una tartaruga, un carabo, una lepre.
55
Mi hanno investito del ruolo di insegnante. Molti interpellati prima di me hanno declinato, spesso, sono convinto, per un ormai sopraggiunto abbruttimento, misto a rassegnazione e mancanza di fiducia nel futuro. A che pro insegnare qualcosa che vada oltre la fruttifera tecnica di cattura di una pernice o di un coniglio selvatico? Perché perdere energie in sterili costruzioni colloquiali quando abbiamo enormi problemi da risolvere se vogliamo conservarci vivi, ammesso che questo sia vivere?
Questa immeritata qualifica tuttavia non mi è sgradita, anzi. Ma la difficoltà di rapportarsi con bambini che non hanno alcuna esperienza diretta della civiltà da cui proveniamo rende arduo comunicare loro nozioni di storia, arte o geografia. Somme, divisioni, triangoli e circonferenze hanno al contrario miglior presa sulle loro menti, ma assolvo questo mio compito all’ombra del dubbio: il far di conto troverà applicazione in qualche frangente delle loro vite? Il solo pensare che mai coloro ai quali gli insegnamenti sono indirizzati li metteranno in pratica o potranno tradurli in atti all’interno di un contesto civile, quale che esso sia, mi fa rabbrividire. Forse non ha senso, anzi so che non ha senso, non più almeno; ma siamo uomini (ma ancora possiamo dirci tali?) e poco ci resta per rimanere ancorati a questa consapevolezza, e quel poco è racchiuso nelle parole di qualche filosofo, in qualche verso, nella netta, certa, incorruttibile e solida sistematicità di un calcolo, nell’indimostrabilità di un postulato.
Talvolta cado in dimenticanze, evento del tutto normale che però mi scaglia nell’orrore. Impossibile è infatti sanare la falla in questione: non un testo, non un qualsivoglia ricettacolo di informazioni cui ricorrere è disponibile. Di rado altri riescono ad ovviare al difetto: l’oblio ha ammaliato le menti, le urgenze quotidiane le hanno ghermite e deportate in territori ove non si esercita conoscenza. Il nostro è un mondo ribaltato, ciò che più occorre è forza di braccio, piede fermo ed occhio acuto.
E’ perciò il mio un discontinuo trasmetter nozioni, senza regole e disordinato, parlo di ciò che voglio e soprattutto di ciò che vogliono i bambini, in modo che non divenga per essi un peso, giacchè sarebbe inutile. Non io posso insegnare come costruire un arco, conciare una pelle, cucire una suola di scarpa o men che meno come fare di un parafango un vomere, di un albero di trasmissione un succhiello, di una ruota una noria. Questo è compito di altri, le mie mani si rifiutano di modificare gli oggetti, di trasformarli per adattarli a tutt’altre funzioni rispetto a quelle per cui furono forgiati in fabbrica o assemblati in catena di montaggio. Non ne sono capace, non riesco a leggere in una semplice forma un possibile utilizzo, anche se mal adeguato. Non ho questo dono, per me un paraurti resterà sempre un paraurti, un cerchione un cerchione ed una valvola una valvola.
L’abilità manuale si è rivelata preziosa, grazie ad essa gli automezzi sono stati smembrati, sezionati e trasformati. Il processo di metamorfosi ha generato ogni sorta di utensili, benchè poco ortodossi; le carcasse sono state via via mutilate, sventrate, rose e tarlate sempre più in profondità fino a lasciare ben poco degli originari corpi.
I detriti e la polvere portati dal vento e accumulati nelle minuscole anfrattuosità dei rottami hanno fatto di essi microscopici mondi vegetali. Nei centimetrici pozzi di coclea un capello di festuca verdeggia in luogo di un bullone; teorie di fori imbutiti, orfani delle viti, ospitano cuscinetti muscosi. Gracili e spente infiorescenze rendono stagionale omaggio ai rufi scheletri, ultimi
simulacri delle carcasse ferrose giacenti, deturpate, sconciate, ed infine divorate dall’ostinato banchetto di voraci sesquiossidi.
Solo l’asfalto sembra sfuggire allo scorrere del tempo. Questa striscia maledetta permane nera, liscia, incorrotta, immune a qualunque assalto che piova dal cielo in forma di atmosferile o sorga dalle viscere della terra in forma di radice. Ancora oggi ci ammonisce, esortandoci perentoria ad esser pronti a riavviare i motori vegetati, a riprendere posto alla guida, ad abbandonare finalmente l’ordalia, scheletri negli scheletri. Somma gioia sarebbe vedere un mattino questo nastro principiare a segnarsi di cicatrici, a sconvolgersi nel caos del degrado, ridursi a poco a poco a un gioco di tessere, nere e galleggianti sulla nuda terra sottostante.
Ma non basta. Gli stessi ignoti architetti che hanno reso quest’opera una materiale violazione delle naturali leggi del disfacimento hanno chimicamente instillato l’infausto sortilegio nella vernice dell’automobile gialla in cima alla salita, unico punto colorato in mezzo all’oceano di ruggine. Punto colorato che permane.
Permane.
Permane….
89
Spesso mi allontano con lo sparuto gruppo di bambini e ragazzi, seguendo l’intreccio di sentieri che fiancheggiano la strada, sentieri prodotti dal nostro continuo e bolso andirivieni verso il ruscello, attraverso gli stentati orti e lungo i percorsi di caccia. Ci sediamo su qualche pietra tra le tante che affiorano intorno come gigantesche vertebre denudate ed osserviamo la forma delle nubi, lo scorrere delle loro ombre come eterei drappi adesi alle forme del paesaggio lontano. E osservando quei figli con i miei occhi gravati da palpebre sempre più trasparenti e pesanti, studiando il loro incosciente, caparbio vivere, paghi di quelli che noi, invece, definiremmo tristi scampoli d’esistenza, insufficienti briciole di immanente, penso che qualcuno di loro si staccherà da questo eterno nastro d’asfalto.
Sì, qualcuno di loro saprà staccarsene, potrà dare corpo a ciò che per noi è solo pura speculazione. Noi non possiamo: il germe della speranza, della speranza di un ritorno alle condizioni di un tempo che conserviamo nel profondo e che gelosi alimentiamo, ci impedisce qualunque azione che vada oltre al soddisfacimento delle necessità primarie. Ognuno di noi vecchi ha una sua candela posta sul cuore orfano, ed è suprema missione mantenerla accesa, porgendo sempre nuova cera per scongiurare il buio, la tenebra che altrimenti ci ingoierebbe.
Ai nuovi, a loro, è demandato ogni pensiero volto al futuro.
Se tutti un giorno decidessero di avviarsi verso l’ignoto lasciandoci qui a languire non potremmo biasimarli, anzi tenteremmo di spingerli innanzi, di vincere le loro residue titubanze.
Per loro e per onorare questa mia estrema missione, ho raccolto tutti i testi che ho potuto trovare presso i miei compagni. Guide turistiche, settimanali, quotidiani, manuali tecnici, biglietti, pieghevoli, persino qualche romanzo, qualche decina di volumi in tutto che ho disposto nell’auto di Rati.
Ho cercato così di lenire la sua umile sofferenza, discretamente manifestatami invocando la corporeità squadrata dei libri, dei suoi libri irrimediabilmente perduti. Per lui non sembra essere un vero problema il non poter più contare sui contenuti (pur sempre grossolanamente conservati nella sua memoria). E’ piuttosto terribile il non poter più avere il soddisfacimento fisico dello sfiorare le pagine, del percepire l’odore della carta, del vedere i volumi allineati e giustapposti, suddivisi in centurie, poste a strenua difesa dei salienti di confine di fronte alla barbarie montante.
Ha accolto con gioia l’affidamento dell’accozzaglia di pagine stampate che ho racimolato. Ha disposto volumi, riviste e pieghevoli con deferenza nel suo ricovero, ordinandoli come avrebbe fatto un coscienzioso bibliotecario, registrandoli nella memoria, accudendoli come figli.
Nonostante l’evidente povertà di quelle poche pagine scritte, che pure andavano lentamente aumentando di numero, ho visto Rati innumerevoli volte scorrere i pochi elementi dello scarno simulacro di biblioteca. L’ho visto assorto nella consultazione ora di un pieghevole, ora di una rivista, ora di una cartina stradale, assorbito da chissà quale bizzarra ricerca. Più di una volta mi ha
fatto notare strane relazioni emerse dai suoi studi, al contempo mettendomi in guardia circa la possibilità, tutt’altro che remota, che tali apparenti relazioni altro non fossero che semplici coincidenze, frutto della sola casualità.
Ma, sosteneva, inquietante era il fatto che l’ordine sotteso da quelle relazioni trovasse modo di esplicitarsi anche in un insieme come quello, esso stesso casuale e composto, tutto sommato, di ben pochi elementi.
Eppure come interpretare l’innegabile fatto che più spingeva in profondità l’esame dei documenti e più rifletteva sui loro contenuti, tanto più si trovava a dover aggiornare l’elenco di coincidenze, relazioni, somiglianze, correlazioni, analogie, similitudini, legami e corrispondenze?
Infine un giorno, forse pentendosene in seguito, mi accennò un suo pensiero. Lo fece come se stesse per formulare qualcosa di estremamente pericoloso e sovversivo; esitando e interrompendosi più volte e dopo aver premesso che si trattava solo di illazioni prive di reale giustificazione.
Disse che, secondo ciò che innegabilmente sembrava, sentiva di poter pensare che, oggettivamente, dalla “biblioteca” emergesse un contenuto assai simile ai motivi architettonici fondamentali della realtà, alla sua struttura sottostante, alla sua raffigurazione in forma di immagine ectoplasmatica. Insomma, ammise, infine esausto dopo tanto esitare, che la “biblioteca” conteneva la sinopia del mondo.
Ho così letto nei suoi occhi di grigia acqua il riflesso della nostra pazzia.
144
Rati è morto.
Stamane non è uscito dal suo rifugio per fare la consueta passeggiata, la sua sagoma è rimasta ferma sul sedile semireclinato e abbiamo dovuto constatare il decesso, avvenuto senza apparente motivo.
Sono smarrito e disperato.
Ho accettato la fine del mondo che conoscevo, l’attesa senza soluzione, le privazioni continue, l’inevitabile decadimento fisico e mentale, perfino l’inaudito scemare della speranza di potermene andare da questo luogo. Ma ora tutto è veramente finito. Il mio amico ha preso la fortunata via prima di me, lasciandomi di fronte solo il suo guscio terreno, un etereo derma resto di una muta animale.
In compagnia delle parole di Rati ho in passato lungamente riflettuto ed oggi ancora egli mi lascia un estremo testamento che leggo nei suoi occhi spenti.
Il nostro rapporto con la morte è cambiato.
Da un passante che finiamo per urtare a mezzo della nostra corsa trafelata, sospinti quasi alla cieca dalle correnti, essa è divenuta una sorta di presenza ubiqua e insistente, un vincolo imprescindibile. E questo non perché chi di noi ci ha lasciato lo ha fatto sotto i nostri occhi, estrinsecandoci ogni istante della sua sofferenza, esponendoci ogni timore prima di intraprendere l’estremo suo viaggio, chiedendoci aiuto vanamente e disperatamente, ma piuttosto perché lenta e subdola Lei, l’ultima Signora, ci è entrata nei cervelli. Su di essa riflettiamo, dissertiamo e disaminiamo.
E lungamente così ne contempliamo il volto mentre suoi commensali consumiamo aridi pasti, sitibondi indagandone le pupille senza fondo, alla ricerca di un minimo indizio che ci sveli il suo disumano mistero.
Di essa nulla sappiamo. Dopo migliaia di anni nulla più sappiamo di quanto sapessero i nostri lontani predecessori. Non v’è stato neppure un flebile barlume di conoscenza che abbia scalfito la liscia superficie della morte. Né la scienza più raffinata, né i marchingegni più incredibili né la speculazione più ardita e spregiudicata hanno ottenuto un solo successo, per quanto minimale o persino insignificante. Nulla sappiamo ed a questo punto credo proprio che nulla sapremo mai. E non solo ignoriamo del tutto cosa sia oltre la vita, ci è persino totalmente impossibile definire con certezza ove passi il confine tra l’essere ed il non essere più.
E, pur incapaci di definire questo estremo confine, avevamo relegato la morte al di là della vita, rendendola uno sfuggente spettro incarcerato nella torre più alta e remota nel paesaggio attraversato dalla nostra frenetica corsa.
In noi non c’era tempo bastante per la morte.
Ora, nella catarsi forzosa che ci ha trasmutato, essa è divenuta il necessario catalizzatore.
Non la temiamo, tuttavia.
Di essa abbiamo il rispetto dovuto. E con analogo rispetto siamo ricambiati.
L’abbiamo sottratta all’insulto estremo che per troppo tempo, sordi e arroganti, le abbiamo rivolto.
E con dignità e nobiltà antiche essa si presenta a noi, non più con adunche mani di rapina.
Nondimeno la fine di Rati mi ha inferto un colpo molto duro, che faticherò a stemperare nell’oceanico oblio delle mie future sensazioni.
Ieri sera guardavamo i bambini giocare tra i rottami e si ragionava sul loro concetto di vita così diverso dal nostro. Essi vivono felici, di quella felicità liquida e profonda che si affida alla terra e che da essa stessa scaturisce, un velo d’acqua sorgiva su una lastra di granito. E dopo il nostro lungo filosofeggiare, prima di prendere commiato, Rati ha concluso dicendomi quanto sembrasse insensato che nessuno tra quei bambini avrebbe mai udito il suono di un violino o visto un quadro di Monet.
Siamo noi, i pionieri, i primi sventurati a cadere in questa regione estrema dell’esistenza, coloro che pagano maggiormente; noi che conserviamo ancora qualche brandello consunto di un’esistenza diversa, che ad ogni sospinger di passo ci guardiamo attorno con occhio stupefatto e velato di una nebbia marina, noi a cui sovviene il ricordo del mondo passato e sempre, e ogni ora, scontiamo la condanna di un raffronto tantalizzante.
A noi è riservato l’amaro privilegio di due vite.
233
Le notti sono lunghe e sempre vaste, incombono come ombrellifere immani e vanamente enumero le stelle senza capire, credendo di scoprire una soluzione al feroce scorrere del tempo.
Ma altro non è che l’inganno del voltapietre, che dispone il suo frenetico zampettare seguendo la risacca in un ciclico gioco di segni e cancellazioni. L’essere umano traccia il segno e la natura cancella, come se fossero antagonisti in perenne agitazione sotto un superiore e sdegnato sguardo.
Qualcosa di tanto in tanto emerge ancora dalle profondità della mia memoria sensoriale, e più di tutto l’odore volgare delle città, stordite dai loro stessi umori corrotti e affondate nella densa immobilità della controra, al colmo dell’estate.
Eppure, in momenti stranieri, a mezzo di giornate solitarie, ancora mi sorprendo a seguire l’occhio che s’intrufola nel disordine verticale tra le fronde, avido di geometrie urbane che da tempo sono sprofondate nelle sabbie della mia mente. O l’orecchio che riconosce nella danza dell’acqua tra i sassi del torrente l’ipnotico stillare di latta della pioggia nella grondaia. In questi istanti il mio corpo ricorda per me, i sensi sfuggono alla guardiania della ragione e rivendicano la propria sovranità bestiale, ratificata dall’antica consuetudine di forme e di colori, di odori e di suoni che non sono più. Con sofferenza debbo rendere impotenti queste forze primitive, ma è un vano risospingere al fondo borgognoni che tornano inesorabili ad emergere nella bonaccia dei ricordi. E nei giorni peggiori tale è la forza della reminiscenza da costringere le mie gambe a muovere passi frenetici alla rincorsa del rispetto di scadenze e di orari fantomatici. Mentre i miei compagni guardano attoniti il mio guadare precipite tra loro, lotto disperatamente per riprendere il controllo, mi costa inaudita fatica imporre nuovamente il dominio della mente sui sensi e sulla loro scatenata ribellione. Gli sventurati interrompono per un istante i loro lenti e posati gesti, seguono brevemente la folle corsa e poi, senza una parola, riprendono il loro operare tranquillo, ormai avvezzi al mio come ad altrui bizzarri comportamenti. Ognuno conduce in silenziosa solitudine la propria lotta, non riusciamo ad aiutarci in questo affrontare i fantasmi della nostra vecchia vita; troppo diversi sono i nostri animi ed il loro rapporto con la nostra sensorialità, e ancora difformi i volti dei ricordi di ciascuno. La nostra cooperazione non può che essere limitata al reciproco aiuto
necessario per la semplice sopravvivenza; oltre questo non abbiamo modo alcuno di regalarci il benchè minimo giovamento reciproco, siamo tutti isolati dal mondo (ma c’è ancora un mondo oltre l’orizzonte?) ma ciascuno è intimamente isolato dagli altri. Ci troviamo al piede d’una parete vetrificata e scura, ciascuno infinitamente distante dal proprio vicino, ciascuno con una lingua diversa e tutti con lo sguardo fisso alla immutevole sommità.
377
Ormai intravediamo le regioni estreme dell’esistenza umana, ne intuiamo l’ultimo e più remoto confine, oltre il quale si stende l’infinita multiformità della creazione, increspata dal mutevole ondeggiare di innumeri e diverse, sebbene equivalenti, casualità evolutive.
Seguitiamo consapevoli quest’incerto confine, sforzandoci di non cedere alla tentazione di traversarlo e abbandonarci. Abbandonarci e ricevere sul volto l’ineffabile vento divino che conduce nell’immensa distesa di quanto non è umano.
Perché sappiamo.
Sappiamo che una volta varcata la soglia, non sapremo più regredirne e infinita sarà la dolcezza nel donare le nostre anime contorte alla distensione delle forme vitali pure.
E smetteremo per sempre il nostro stinto abito umano, e vanito sarà il nostro pensiero indagatore, e perso il nostro ostinato numerare il tempo. Come troveremo la forza di rifiutare il blasfemo baratto? Fino a quando accetteremo la consapevole sofferenza e sapremo rifuggire l’inebriante libertà della corsa dell’arvicola, la sublime levità del bagliore di coscienza della silva?
Le stelle.
Le stelle hanno colore, ora vedo. Quei colori brillano chiari, distinti nel minuto pullulare celeste. Non so quale fenomeno abbia prodotto tale acume visivo in me, in tanti tra noi. Così, fra lunghi silenzi, consideriamo tanta bellezza, sfuggita ai nostri antichi giorni cittadini.
E’ questo il concambio?
E’ questo?
I sogni.
I sogni da tempo lontano si son fatti continui.
Ed ampi.
Popolano con insistenza lo spazio del sonno e là respiro finchè ogni mattina mi porta allo sventramento, quando mi trovo davanti l’asciutto orrore della realtà….
610
La mia giberna è vuota, da giorni alimento questa consapevolezza.
Le mattine sono dolorose, i risvegli sempre più difficili. Arduo mi riesce delimitare il territorio del sogno e discernerlo dalla realtà; passo parecchio tempo sospeso in luoghi che non riconosco e poi, con moto sempre più rapido, scivolo e precipito con un tonfo nel chiarore del giorno ormai fatto. Cammino a stento, le ginocchia mi reggono solo a prezzo di indicibili dolori e pertanto cerco di limitare i miei spostamenti. Talvolta debbo essere aiutato e questo esser di peso ai miei scarni compagni mi frustra oltre ogni misura.
Ma questa mattina è diversa.
L’aria ha un profumo leggero e strano ed è tiepida e fresca insieme. Dovrebbe esser ancora freddo, la buona stagione è appena principiata, ma oggi tutto è diverso. Persino la vista mi gratifica di soddisfazioni precluse da molto tempo. Distinguo esaltanti particolari nel paesaggio, tutti i contorni sono netti, luminosi, a tratto sicuro e incisi sono i bordi delle nuvole, splendenti le erbe.
Qual è il senso di questo rifiorire dei sensi? Che cosa nasconde? Ho imparato che c’è sempre un prezzo da pagare, quindi diffido.
Nondimeno è meraviglioso abbandonarsi a queste sensazioni, lasciare che tutto fluisca e si riversi dentro di me attraverso la mia pelle, i miei occhi, le mie narici, per poi gonfiarsi nel cervello come una grande mongolfiera che mi trascina in alto…e lontano.
Mi sembra di sfiorare con la mano le infinite spighe lungo un declivio che si perde verso l’orizzonte ondulato di colli, scorgo casolari che mai avevo notato, isole tra ombre verdi che s’allungano verso i fossi, tra i filari dei pioppi.
Tutto ha cambiato volto stamane….tutto è dolce….Voglio sedermi un istante e assaporare questo momento di sensazioni intense, allungate nel tempo, protese ben oltre il mio essere. Un istante solo, prima che l’afflizione del corpo mi uncini nuovamente, mi inchiodi al marmo glabro della sofferenza.
Una manciata di secondi solamente….adagio le vertebre dolenti alla roccia dietro me, inspiro a fondo, lascio che il mondo fluisca, lo trattengo a lungo….espiro…una volta….poi una seconda…e una terza, con fatica estrema.
Odo un leggerissimo rumore straniero, finora nascosto nello stormire di fronde, un rumore ormai esonerato dai registri della mia mente. Un suono fesso, innaturale, ripetuto su frequenze sempre più alte, discreto ma insistente.
Ma perché nessun altro sembra rendersene conto? Perché tutti si trascinano come sempre, debolmente indaffarati, intontiti nel ripetere i gesti di ogni mattina, incuranti di questa stranezza?
Devo chiamarli, avvertirli….presto…Ma non odo la mia voce, le mie corde vocali sono stremate, aride, non emettono suono, solo un soffio flebile esce dal mio petto incavato ed esausto.
Eppure odo…..distintamente.…Il sole vergine flette i suoi raggi tra le ciglia, scolpisce il tremolio delle mie mani abbandonate al suolo…ecco! Anche loro si rendono conto di qualcosa….hanno sentito….hanno capito…..i ragazzi vengono verso di me correndo, qualcuno mi indica, chiama gli altri…..Ma non capite…perché correte verso di me? Che c’entro io….perchè quelle facce?....E’ laggiù…..vedete? Non vedete che sta arrivando qualcosa?....
E all’orizzonte estremo, al culmine del nastro maledetto, là davanti.….sembra…..non vedo bene….il sole mi abbaglia….tutto…..si fa scuro, ma……ma…..sì…qualcosa…..si muove…appena…..quel tetto giallo…..scorre……in avanti…… lento….finalmente….
Finalmente…..



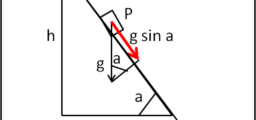


2 commenti
Caro Guido grazie per questo melanconico regalo d'inizio anno. Non sto scherzando, nella mia avanzata età, ormai quasi del tutto trascorsa, mi sono sentito in perfetta sintonia con questa tua storia della macchina gialla all'orizzonte al di là di tutte le altre arrugginite. Con i numeri dei capitoli che procedono dilatandosi.
I tuoi bambini mi hanno evocato le stagioni della vita, la spensierata esistenza di chi non ha ancora accumulato un opprimente bagaglio di ricordi e di cultura. Mi ha fatto pensare ai giovani d'oggi naturalmente digitali, come noi fummo analogici; ma anche ai miei vecchi che cercavano di raccontarmi le loro guerre mondiali, assolutamente incompresi.
Sei stato bravo a evocare tutto ciò dalla semplice visione di un tavolino sulla strada. A me avrebbe evocato al massimo il Carosello del Cynar con Calindri seduto in mezzo al traffico a combattere il logorio della vita moderna.
Grazie Alberto! Per me è molto gratificante leggere le sensazioni che le mie righe hanno evocato in te. Il racconto ed il suo lettore si sono incontrati e ritrovati l'uno nell'altro, potrebbe un autore chiedere di più?
E grazie anche per l'immagine di Calindri! La ricordo come se fossi seduto lì, davanti allo scatolone dall'occhio di vetro con le sue immagini in toni di grigio.